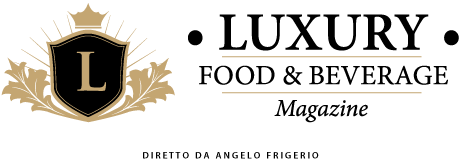La divisa femminile di una Fondazione di sommelier non prevede il pantalone. La cosa non è piaciuta a una corsista. E l’ha rivelato ai giornali, che hanno trattato la vicenda come uno scoop sensazionale. A che punto siamo arrivati?
di Tommaso Farina
La nostra è l’epoca del superfluo. Siamo così pieni di beni di consumo che possiamo considerarci satolli, e dunque quasi costretti a occuparci non più del necessario, ma dell’inessenziale, del voluttuario. Non si può spiegare altrimenti l’ennesima polemica a basso costo, letteralmente una tempesta nel proverbiale bicchiere d’acqua, che ha animato le cronache minori del sempre spassoso mondo enogastronomico.
E che è successo? Che una fotografa americana trapiantata in Italia, Nicole Hesslink, si è iscritta a un corso per sommelier nelle Marche. A un certo punto, le hanno spiegato che la divisa ufficiale dell’organizzazione (anzi, Fondazione) i cui corsi ha deciso di frequentare, per le donne prevede la gonna. Ecco, ora che lo si sa, tutto a posto no? Invece no: alla Hesslink non è andato bene. L’incredibile fattaccio è occorso due settimane fa. La neocorsista ha deciso di scrivere alla Fondazione un’email: “Why is it that we must wear a skirt?”. Ma non si è limitata a questo. A suo giudizio, la questione non aveva comunque la visibilità che meritava un problema tanto scottante e improcrastinabile, roba da far impallidire gli screzi tra Putin e Biden. Così, ecco la pensata: faccio un’istantanea della mia email, e la metto su Instagram. Instagram è un posto bellissimo e poetico. Un posto, soprattutto, dove rivendicazioni di questo genere hanno un ottimo terreno di coltura. Ed è vero che quasi tutti i neo-comandamenti della nuova ideologia cosiddetta ‘woke’ si sono sviluppati in gran parte sui social network, a suon di tweet e di hashtag. Così, naturale che l’intemerata della Hesslink si trovasse nel suo naturale elemento. E non solo: assieme alla sua email, tutto sommato quasi pacata, la fotografa ha riportato anche le normalissime e chiare risposte della Fondazione ai suoi dubbi. E che cosa doveva rispondere, la Fondazione? Ha risposto, con molto garbo, che l’uniforme è stata scelta così per ragioni estetiche. Chiunque, a tal punto, si sarebbe stretto nelle spalle e avrebbe detto “E’ così, proverò a conviverci, al massimo cambio corso”. Ma non è il caso della fotografa: per lei una cosa tanto innocua si è rivelata addirittura scandalosa. Motivo? A lei piacciono di più i pantaloni. In tempi appena poco più civili e meno impazziti dei nostri, si sarebbe levato un corale “E chi se ne frega?”. Oggi la faccenda è invece arrivata addirittura al maggiore quotidiano italiano, il Corriere della Sera, che ha anche dedicato qualche pagina con fotografie non solo alla polemica in sé, ma anche alla polemista. Si potrebbe sorridere e pensare subitaneamente al vecchio adagio di Henry Ford che si ripeteva all’epoca dei nostri genitori: la pubblicità è l’anima del commercio…
Come che sia, sono notevolissimi i commenti apparsi non solo nella blogosfera, ma proprio nel post originale di Instagram. Il più divertente e lunare è quello dell’autrice culinaria Elizabeth Minchilli che, restando seria, tira in ballo un’imprecisata cupola di ‘old white men’ che prendono, a suo dire, tutte le decisioni. Pare di risentire gli slogan, attualmente di moda, sulla mitica ‘dittatura del patriarcato’. Il punto è: anni fa, patriarcato oppure no, tutta questa faccenda si sarebbe meritata un trafiletto? Francamente, credo di no. Anni fa si badava alle cose veramente importanti, e ciò valeva anche per i giornali. Se simili situazioni hanno immeritata visibilità, la colpa è anche un po’ la nostra. Di noi giornalisti. Proviamo a lasciar perdere il superfluo.