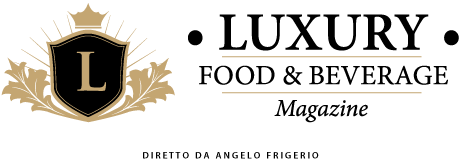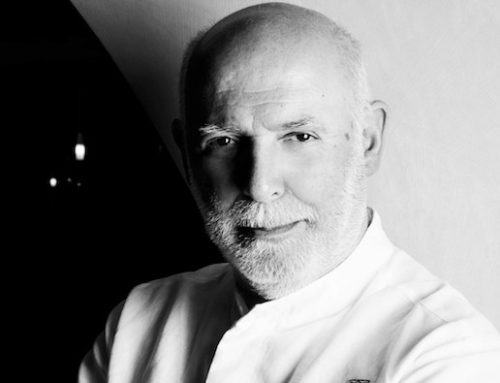Il patron dell’Antica Corona Reale di Cervere, si racconta: dagli inizi del 1815 alle due stelle Michelin, col culmine di una tragedia del Coronavirus affrontata senza licenziare neanche un collaboratore.
di Angelo Frigerio e Tommaso Farina
Ci sono ristoranti d’alto livello che non parlano con la pubblicità mediatica, ma con la loro storia. L’Antica Corona Reale di Cervere, provincia di Cuneo, ha una storia di due secoli, ed è tra questi. Col lavoro di una famiglia, fin dall’Ottocento nelle mura di via Fossano si dava da mangiare ai viandanti, ma è con l’ultima generazione che è avvenuto il salto di qualità. Gian Piero Vivalda, classe 1968, nel 1994 ha dato la svolta, e oggi può fregiarsi di due stelle Michelin: un risultato ottenuto con abnegazione e amore per la tradizione. Oggi la Corona Reale affronta un capitolo assai arduo per la ristorazione di ogni Paese: quello del Covid. Abbiamo incontrato Vivalda, per farci raccontare un po’ la sua storia, e le sfide che vuole affrontare nel 2021.
Come si sente ad avere 200 anni di storia sulle spalle?
Siamo nati nel 1815. Ci chiamavamo Osteria della Corona. Artefice ne fu il mio bisnonno Alessandro. È diventata Osteria della corona reale perché il re Vittorio Emanuele era spesso avventore del ristorante. Questo quando è avvenuto prima della Guerra. All’epoca c’era nonno Eugenio. Certo, al tempo si facevano tre piatti…
Per esempio?
Io ancora non c’ero, mai i piatti erano quelli tipicamente fluviali, la cucina del fiume Po: i pesci di fiume, le lumache, le rane e poi la carne piemontese, finanziera, trippa, bollito. E infine, moltissima selvaggina. In quel periodo Cervere era popolata di cervi, era una riserva di caccia anche per il re: ho tuttora delle foto fantastiche con almeno 30 fagiani, 20 lepri, nelle battute di caccia che il re faceva da Pollenzo alla sua tenuta, fino a Cherasco. Poi arrivò mio padre, Lorenzo, negli anni Sessanta, quasi per dovere familiare. Quegli anni sono stati difficili, perché poi l’osteria era diventata una sala da bar, dove i clienti venivano a giocare a carte e a bere qualcosa. Un po’ il posto pubblico del Paese.
E poi?
Poi nel 1994 ho cominciato io. Negli anni Settanta, il babbo aveva cambiato il nome: da Corona Reale, l’osteria era stata rinominata Da Renzo, togliendo un po’ di allure. Dal canto mio, la mia storia è simile alla sua. Nel senso che fin da subito mi ero detto: io qui non ci rimango un minuto. Ero già stato a Parigi, avevo già lavorato molto dopo la scuola alberghiera. Nei periodi in cui stavo fermo, davo una mano in sala o in cucina: ero l’unico dipendente di mio padre, i pochi clienti comunque mi facevano i complimenti per il mio modo di fare. Facevamo un solo piatto: oggi c’è la faraona, si mangia la faraona. Questo è stato uno stimolo a migliorare, perché poi vicino a noi c’era già qualche ristorante affermato. C’era il Rododendro, a Boves, che aveva già due stelle Michelin. E c’era Guido Alciati a Costigliole d’Asti. La concorrenza non era così agguerrita: c’erano solo due locali stellati dalla Michelin in provincia. Grazie a questo, c’è stata l’opportunità di inserirsi in una fascia di eccellenza, grazie anche a Carlin Petrini di Slow Food. Mangiava tutti piatti della tradizione, dalla finanziera alla trippa. Petrini aveva trasferito la sua residenza a Cervere, e dunque spesso portava a mangiare imprenditori importanti, come Zonin, Illy e altri. Il passaparola ha funzionato. Dal canto mio, ho continuato ad andare in giro per le cucine di tutto il mondo, per affinare le mie competenze.
Ma com’è ricominciata l’Antica Corona Reale?
A diciott’anni, in un mercatino di libri usati a Roma, scoprii un’antica edizione della Guida del Touring, forse del 1923 o del 1913 addirittura. Ci trovai il nostro indirizzo: Corona Reale, Camera 2, via Fossano numero 13. Caspita, eravamo noi. Mi feci la domanda: ma com’è possibile che oggi ci chiamiamo Da Renzo? A quei tempi non sapevo nulla della nostra storia. Mi rivolsi a mio padre: noi abbiamo due secoli di storia, perché non ricuperarla? Ma mio padre non voleva rimettere il nome antico. Per me era diverso, e non era solo questione di nome. Era una questione ideale. Io volevo fare una cucina tradizionale, anche umile se vogliamo, ma sincera. Invece cosa succedeva in quei periodi di bassa affluenza? Magari c’era un matrimonio al sabato o alla domenica, ma per tutta la settimana non veniva nessuno. Mi sono detto: perché non fare due o tre piatti al giorno, anziché uno solo? Nel ’94, mio nonno mi prese da parte e mi disse: tu sei l’unico che può portare avanti l’osteria. Nel novembre del’94 ecco rinascere l’Antica Corona Reale.
Come furono i primi passi?
Fin da subito, grande entusiasmo. C’era già una clientela che ci seguiva con interesse. Dalla nostra parte, avevamo fedeltà alla tradizione e una grande attenzione alla filiera. Quindi già all’epoca io andavo a prendere i capretti a Roccaverano e i capponi a Morozzo. Poi sono arrivati i successi, che alcune volte sono stati difficili da gestire. Ad esempio, il premio di Miglior cuoco dell’anno, nel 2004 è stato per me un fulmine a ciel sereno: tutti si aspettavano di venire a mangiare una cucina da tre stelle Michelin. Poi le stelle arrivarono davvero: la prima nel 2003, la seconda nel 2009. La clientela è sempre cresciuta, almeno fino al 2020.
Già, il lockdown. Come lo avete gestito?
Quanto abbiamo perso in termini economici non lo so. Quel che è so, è che non abbiamo licenziato nessuno. Non abbiamo messo nessuno in cassa integrazione nel 2020. Ho promesso che avrei fatto così. Nel 2016 avevamo creato il laboratorio dei panettoni, e ciò oggi ci ha consentito di spostare alcuni collaboratori dal ristorante al nostro Atelier Reale, a fare panettoni e colombe a mano. Abbiamo salvato anche dei posti di lavoro. E poi naturalmente quando ci hanno lasciato aprire abbiamo fatto anche nuovi investimenti. Quest’anno è nato il Gelato Reale, servito nel déhors del ristorante: una serie di sorbetti con la frutta fresca, le pesche di Canale, le fragole di Peveragno, le ciliegie di Pecetto. È piaciuto molto, ed è piaciuto anche il delivery, purtroppo. Dico purtroppo perché se in una giornata normale tu fai 100 coperti con una certa cura per arrivare a fare i piatti perfetti e caldi, un delivery fatto allo stesso modo ti costa il 200% in più di fatica e accorgimenti, tra distanze da mantenere e cotture separate. Morale: è come se Maradona dovesse battere un calcio di rigore non più da 11 ma da 111 metri. Non mi ritengo un Maradona, ma la difficoltà è stata veramente tanta. La clientela ci è stata vicina.
E qual è il rapporto che dovrebbe esserci tra la cucina e il territorio?
Se io, cliente occasionale, guardo fuori dalla finestra del ristorante e vedo il mare, e poi nel piatto mi trovo il capriolo, mi faccio qualche domanda. Lo stesso se mangio branzino e ho le montagne intorno: non è l’idea di cucina che vorrei. Si badi bene: la mia idea non è neanche una cucina a chilometri zero, perché non è detto che a 50 chilometri di distanza ci siano delle cose migliori o peggiori di quelle che trovo a cinque. Però ci vuole coerenza. Se tu cominci a metterci dentro le erbe giapponesi, i fiori, gli agnelli che invece di arrivare da Sambuco e dal cuneese vengono invece dalla Nuova Zelanda… E poi, i giovani. Quando arriva un ragazzo in cucina, la prima cosa che gli chiedo è: sei capace di sfilettare? La risposta, spessissimo, è un sonoro no. Nel 90% dei casi non ha fatto la scuola che c’era una volta, quella dei Troisgros, dei Bocuse: lì, prima di avvicinarti alla stufa, dovevi anzitutto imparare a sfilettare il pesce, disossare i piccioni. Poi, dopo passavi ai fondi di cottura, e più avanti ancora, alle salse. Dopo sei anni, forse potevi avere il munifico privilegio di fare un’omelette. Adesso invece vogliono tutti andare ai fornelli con lo chef.
Lei spesso ha detto non parla di clientela ma di famiglia. Una famiglia con cui condividere, in un mondo attuale apparentemente privo di confini e di radicamenti, il legame più vero con il luogo in cui abitiamo e che a sua volta abita in noi…
È vero. Quando ho bisogno di ispirazione vado nei miei orti, oppure nella vallata dove la mia famiglia stabilì le sue tenute: un mondo di peperoni, porri, rape. Molti piatti miei e della mia brigata sono nati da un’ispirazione che ho avuto lì. Quando vedi un quadro di Chagall, rimani rapito. Poi, quando vai in certi luoghi, in mezzo ai colori, magari non capisci come ha fatto a dipingerlo, ma sicuramente intuisci come lo ha concepito. Ti coinvolge. La cucina è coinvolgimento.
Avete buoni rapporti con i produttori e le aziende del luogo?
Personalmente ho alta considerazione di aziende piccole e anche più grandi, come Inalpi. Anzi, con loro ho un rapporto particolare. Ci siamo incontrati per caso dieci anni fa. Da subito abbiamo condiviso l’idea più importante: l’eccellenza dei nostri prodotti come traguardo da raggiungere. Una cosa su cui siamo sempre stati d’accordo, è che il nostro dovesse essere il migliore panettone, il miglior burro, il miglior Bra duro d’alpeggio. Su questo abbiamo lottato veramente, anche dopo iniziali scetticismi. Abbiamo iniziato un percorso insieme, con gli Invernizzi facciamo ricerca e sviluppo, e con loro abbiamo creato una fonduta con il nostro nome. E ci sono in ballo anche altri progetti per il futuro.
I tuoi tre piatti-bandiera?
Sarò un po’ campanilista, ma comincerei con l’anguilla in carpione, perché rappresenta una tradizione della nostra cucina di fiume. Poi, la finanziera, che era il piatto preferito dell’alta finanza e dell’alta società torinese, a partire da Cavour. È una pietanza in cui entra tutto il quinto quarto del vitello: cervella, filoni… È una specie di manifesto del Piemonte a tavola, quello che la bouillabaisse è per Marsiglia. L’ultimo grande piatto che prediligo è l’uovo in cocotte con il tartufo bianco d’Alba, il piatto che ci distingue di più al mondo.
Abbiamo archiviato il disastroso 2020. Come sarà il 2021?
Beh, non potrà essere peggio dell’anno appena trascorso, a meno che non succeda l’irreparabile. Ma occorre guardare avanti, e non indietro. Se ci sono dei dati da giocare, li getteremo sul tavolo senza indugio. Ripartiremo con lo sforzo fatto nel 2020 di non lasciare nessuno per strada, e di fare in modo che il cliente che torna nel 2021 potrà trovarsi bene come gli capitava all’inizio del 2020, quando nessuno ancora poteva nemmeno prevedere quello che sarebbe accaduto. Tutto ciò non sarà affatto scontato, ma per noi riuscirci sarà il successo più bello.