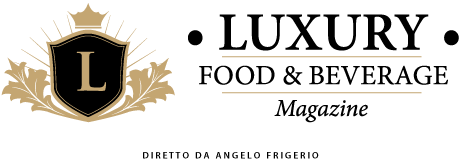La lettera di un detenuto del carcere Due Palazzi di Padova alla madre. Il lavoro nella Pasticceria Giotto, il laboratorio artigianale aperto nel penitenziario. Il riscatto e la fatica. L’orgoglio di “essere uno che fa la sua parte, come tutti gli altri”.
Per qualcuno il lavoro è una gabbia senza via d’uscita. Per altri, i detenuti, invece, è proprio il lavoro a offrire un affaccio su quella che siamo soliti chiamare ‘normalità’. Per chi sta scontando una pena, è una seconda occasione: l’opportunità di crescere, ricominciare e costruire un futuro oltre le mura del carcere. La persona, grazie al lavoro, non viene definito solo dal suo errore. Ha invece l’opportunità, una nuova, di essere qualcosa in più. ‘Seconda Occasione’ è proprio il nome della newsletter mensile di Pasticceria Giotto, aperta nel 2005 all’interno del carcere Due Palazzi di Padova. Racconta la vita all’interno del laboratorio, dove alcuni detenuti, affiancati da maestri pasticceri, sfornano quotidianamente dolci artigianali. Ogni uscita racconta una storia diversa, nell’incontro tra la normalità del lavoro e la sospensione delle libertà. L’ultima riporta una lettera, inviata alla madre, da un detenuto attivo nel laboratorio. Scrive della vergogna e del senso di colpa provati per aver sempre chiesto qualcosa alla famiglia. E, soprattutto, del “contrappeso” che costituisce il lavoro nella Pasticceria Giotto, che gli serve per sentirsi “uno che fa la sua parte, come tutti gli altri”. A testimonianza, appunto, della bellezza delle seconde occasioni. Ecco di seguito, la commovente “Lettera da un detenuto che deve togliersi un peso”.
Cara mamma,
Scusate se ci ho messo un anno a scrivervi una lettera che non fosse solo “sto bene, mandatemi i calzini”.
È che certe cose non ti vengono fuori subito, ci devi convivere un po’, come quando l’impasto deve stare lì a riposare e non lo devi toccare se no rovini tutto.
Nonostante le giornate adesso scorrano decisamente più veloci, non è che se inizio a lavorare alle quattro di mattina allora tutto il resto scompare. La cella è sempre quella, il rumore delle chiavi pure, e quel senso di schifo che provo quando penso a quanto vi sono costato in questi anni non se ne va con la doccia. Non mi sono dimenticato neanche per un momento che per colpa mia avete dovuto tirare la cinghia; i soldi per l’avvocato, i pacchi che mi spedite. Mi sono sentito un investimento fallito, un debito che non riuscivate mai a estinguere.
Mi viene in mente l’ultima telefonata. Quella in cui non vi ho chiesto niente. È strano, ci ho pensato solo dopo. Per anni le mie parole sono state solo “mi serve”, “mi mandate”, “non ho più”. Ero un parassita col numero di matricola. Mi vergognavo cosi tanto che a volte avrei preferito che non rispondevate al telefono. Invece l’altro giorno abbiamo parlato solo di dove saremmo andati a farci un giro quando esco, è stato come se per un attimo il telefono non bruciava più.
Mica i soldi della pasticceria cancellano tutto, faccio ancora un po’ di fatica quando penso che per voi non sapevo fare niente, ma almeno adesso questo peso che sentivo dentro ha un contrappeso. Non è da molto che non mi sento solo una bocca da sfamare a distanza, ma un paio di mani che, pur stando chiuse qui dentro, riescono ad arrivare fino al tavolo della vostra cucina.
Fuori magari pensano che siamo qui a decorare torte per passare il tempo e diventare più buoni. La verità è che è un lavoro che ti spacca le gambe e ti costringe a stare attento a quello che fai, se no butti via tutto. Ma mi serve. Mi serve a sentirmi uno che fa la sua parte, come tutti gli altri.
Vi scrivo perché a voce mi vergogno ancora, ma sappiate che ogni volta che sento l’odore del burro, spero che arrivi fino a voi e vi faccia sentire un po’ meno stanchi di me.
Dai un bacio a Luisa e alla piccola. Dille che se vuole chiamarmi adesso che non sono più “solo un mantenuto” a me fa piacere, non ce l’ho con lei se lei non ce l’ha con me.
Ci sentiamo sabato, come sempre.
Vi abbraccio.